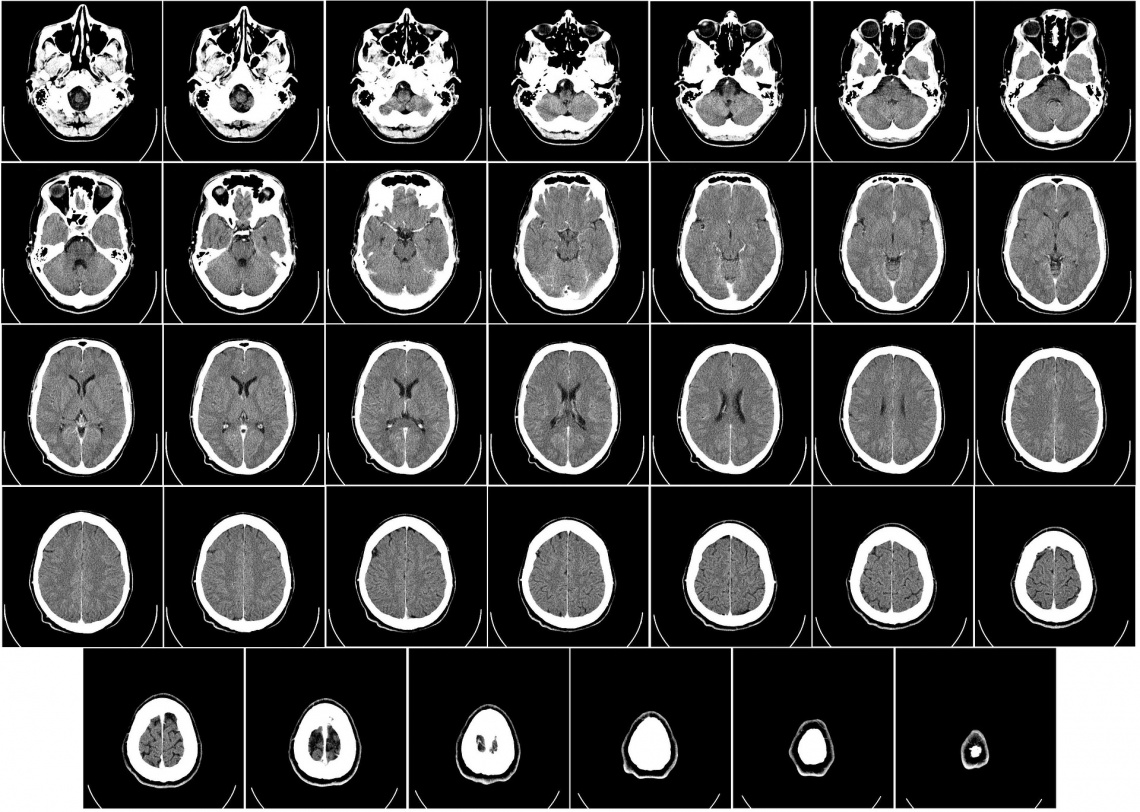Il risarcimento da errata diagnosi
In ambito medico la diagnosi viene definita come “la determinazione della natura o della sede di una malattia in base alla valutazione dei sintomi.” La determinazione della diagnosi è necessaria per prestare le opportune e dovute cure al paziente, la prescrizione dei necessari esami strumentali specifici per la valutazione della malattia, la cura farmacologica adatta.
Il medico, come in qualsiasi altra professione, potrebbe però incorrere in errori della diagnosi, errori che potrebbero peggiorare, anche in modo sensibile la vita del paziente, per mancanza di tempestività ed incisività delle cure somministrate: in effetti, potrebbe accadere che il medico non riconosca o approfondisca la sintomatologia riscontrata sul paziente; non prescriva al paziente test specifici al fine di confutare la diagnosi ovvero non interpreti nel modo corretto alcuni risultati dei test prescritti; non richieda un approfondimento diagnostico con qualche ulteriore specialista ovvero non richieda al paziente di sottoporsi ad un controllo periodico nel tempo per comprendere l’eventuale evolversi della malattia.
Nell’ottica degli esempi indicati, che potrebbero essere solo alcuni delle possibili fattispecie riconducibili all’errata diagnosi, il paziente subisce un’alterazione del proprio stato di salute - situazione che può, nei casi più rari o più gravi, condurre persino alla morte – tale da comportare un danno, comunque, una volta dimostrato l’errore diagnostico, come risarcibile.
Il danno, riconosciuto inizialmente dalla giurisprduenza più autorevole come danno da perdita di chance, viene considerato come quella menomazione del paziente dal sottoporsi alle giuste cure, al sottoporsi a cure meno gravose per il proprio fisico poiché la corretta diagnosi è stata tardiva, ovvero l’impossibilità di sottoporsi a cure salva-vita per l’intempestiva diagnosi corretta. Il paziente, nel momento in cui comprende che la diagnosi è stata errata o tardiva, non ha la medesima possibilità di scegliere la cura migliore per sé, avendo essenzialmente "perso" del tempo e delle opportunità di cura tempestive, qualora la diagnosi fosse stata corretta, o per quel paziente che si ritrova con un’aspettativa di vita sensibilmente ridotta a causa dell’intempestiva corretta diagnosi. Si pensi ancora a quel paziente che, seguendo una cura legata alla diagnosi errata, non veda mai migliorare il proprio stato di salute e quando scopra che la terapia effettuata, come conseguenza di errata diagnosi, sia stata inutile, lo stesso non abbia più fiducia nel proprio curante o abbia irrimediabilmente perso l'opportunità effettiva di curarsi.
La giurisprudenza della Suprema Corte è stata molto dibattuta negli ultimi anni, considerando tra l’altro che numerose riforme legislative sono state introdotte nel nostro sistema. Di particolare pregio, in tal senso, risulta la sentenza della Cassazione sez. III n. 10424/2019 nella quale, tra l’altro, si legge: “questa Corte - con riferimento a fattispecie di omessa tempestiva diagnosi … ha ritenuto erroneo affermare che tale condotta "non abbia inciso sulla qualità di vita" del paziente; una simile affermazione, infatti, non tiene in debito conto, innanzitutto, la possibilità che - nel lasso di tempo intercorso tra "la diagnosi errata e quella esatta" - il paziente abbia visto "perdurare il suo stato di sofferenza fisica senza che ad esso potesse essere apportato un qualche pur minimo beneficio perché vi era stata quella diagnosi erronea" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 18 settembre 2008, n. 23846, Rv. 604659-01).”…”…il ritardo diagnostico (peraltro, acclarato come sicuramente negligente) ha determinato - come sottolineato, di recente, da questa Corte, sempre con riferimento a fattispecie analoga a quella oggi in esame - "la perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non configurabile alla stregua di un «quantum» (eventualmente traducibile in termini percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo la definizione elementare della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla responsabilità civile), ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 marzo 2018, n. 7260, Rv. 647957-01).
È, dunque, la lesione di tale libertà che è rimasta priva di ogni considerazione da parte della sentenza impugnata, ovvero quella di scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, una situazione, questa, meritevole di tutela "al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta" (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.).
Del pari, questa Corte ha sottolineato l'autonomia che tale tipo di danno presenta rispetto a quello da "perdita di chance", pure ipotizzabile in caso di "malpractice" sanitaria. Si è, infatti, affermato che, quando "la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, «in pejus», sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente", si è in presenza di un "evento di danno" e di un "danno risarcibile" che è "in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita", da intendere anche "nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo", e ciò "senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance" (così, in motivazione, Cass. 9 marzo 2018, n. 5641, non massimata sul punto).
In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce, nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione o, in alternativa, di una più prolungata – e qualitativamente migliore - esistenza fino all'esito fatale), ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine", giacché, tutte queste scelte "appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.).
Rileva, in tale prospettiva, innanzitutto la legge 15 marzo 2010, n, 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), recante un "corpus" di norme aventi come scopo, tra l'altro, anche - art. 1, comma 3, lett. b) - la "tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine". Non priva di rilievo è, poi, la stessa legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la quale - all'art. 4 - riconosce ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, "in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte", la possibilità sia di "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", sia di nominare, al medesimo scopo, un fiduciario, stabilendo, nel contempo, che tali direttive anticipate sono "rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento".
Orbene, l'autodeterminazione del soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione, perché "anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.). Insomma, per citare una delle voci più alte della letteratura del 900', l'ordinamento giuridico non affatto è indifferente all'esigenza dell'essere umano di "entrare nella morte ad occhi aperti".